Le lucciole, la petèera, la dote, el cibalo, le suocere. Gianvi Lazzarini fa memoria delle cose che non ci sono più
Oggi, in tutti campi della vita individuale e collettiva, usiamo un numero infinito di cose che prima non c’erano o, se c’erano, erano ben diverse da quelle attuali. Il primo scontato riferimento: la gamma enorme degli strumenti di comunicazione. La telematica ha trasformato il computer e ha dato avvio alla “rivoluzione” di Internet che ha permesso, a livello globale, un inedito e straordinario processo di comunicazione di tipo interattivo.
Il discorso su questa tematica è talmente ipercomplesso da farmi preferire l’altra faccia della medaglia: parlare di alcune “cose” che c’erano un tempo e che ora sono scomparse. Le ho scelta senza alcun criterio “oggettivo”, se non quello dell’alone di nostalgia che le accompagna nella mia memoria.
UN TEMPO C'ERANO…
LE LUCCIOLE
Nel febbraio del 1975, pochi giorni prima di essere ucciso, Pier Pasolini scrisse sul Corriere della sera l’articolo La scomparsa delle lucciole. Nei primi anni Sessanta, a causa della contaminazione dell’aria, dell’acqua e dell’inquinamento luminoso, le lucciole sono cominciate a diminuire inesorabilmente. In poco tempo, erano sparite. Utilizzò questa immagine per rappresentare un drammatico mutamento storico e antropologico, che egli considerava un “genocidio”. La scomparsa delle lucciole (ma potremmo dire anche delle rondini, delle rane, delle talpe, di tante specie di farfalle…) coincide con una radicale trasformazione collettiva che, sotto la spinta dell’industrialismo e del consumismo, ha cambiato radicalmente la coscienza e i comportamenti degli italiani.
Ricordo con nostalgia i momenti in cui nelle incantevoli sere d’estate degli anni 50, nell’oscurità notturna di un prato, all’improvviso, piccole luci iniziavano ad accendersi sospese nell’aria. Volavano lentamente e, in poco tempo, c’erano ovunque: puntini che brillavano e oscillavano.
Non è una scena di un romanzo o film fantasy, ma lo spettacolo che accompagna il “corteggiamento” e la riproduzione. I maschi si riuniscono di notte e fanno lampeggiare le loro luci per attirare le femmine. Sono loro che si “offrono”, per cui la metafora “lucciole” per designare certe signore inverte, quindi, il ruolo dei maschi e delle femmine…
LE SUOCERE
Negli ultimi decenni la tradizionale figura della suocera, cioè la madre dei due rispettivi coniugi, ha subito rilevanti modifiche. La suocera, fino a pochi decenni fa veniva in genere ritratta come la "croce" del coniuge del figlio/della figlia. Detti del linguaggio comuni, proverbi, barzellette propagandavano questa immagine: “Tra la suocera e la nuora è il diavolo che lavora”, “La vipera che morse mia suocera morì avvelenata”, e così via.
L'immagine della suocera autoritaria, ficcanaso ha avuto origine nella cultura contadina ottocentesca ed è arrivata fino alla soglia dei nostri giorni. E se oggi, in molti casi non ha più motivi di esistere, allora, di ragioni, ne aveva da vendere, perché le famiglie ottocentesche erano fortemente patriarcali e spesso la nuora entrava a far pare della famiglia del merito e quindi se la doveva vedere con lei, dando prova di affidabilità e sottomissione alle regole della casa. Come madre dello sposo e moglie del capofamiglia accentrava nelle sue mani ogni potere nel campo della gestione domestica, dall’allevamento dei figli, alla cura della casa.
Oggi il tipo di famiglia è cambiato, per cui è abbastanza raro che il marito o la moglie entrino a far parte della famiglia dei loro genitori. Nell’epoca che definiamo postmoderna quando nel linguaggio comune parliamo di famiglia ci riferiamo, solitamente, alla famiglia nucleare, formata dalla coppia coniugale con o senza figli o da un singolo genitore con figli. Ma l’influsso della “madre”, soprattutto del figlio maschio, si manifesta ancora, sia pure in modo inedito rispetto al passato. I figli tendono ad uscire di casa molto tardi, anche perché non indipendenti economicamente: inoltre capita che quando costituiscono la coppia coniugale, quale sia la sua forma giuridica, incorrono molto spesso in crisi, rotture, separazioni, divorzi, per cui è possibile il ritorno nei nuclei d’origine, in certi casi con i propri figli… Allo stesso modo anche per i genitori, e per la mamma in particolare, diventa sempre più difficile lasciare andare i propri figli e ammettere che siano cresciuti: queste mamme chiocce risentono fortemente di questo momento e tendono a rimandarlo il più possibile. Ma l’uscita di casa è sempre più generalizzata e la suocera non può più assumere, in genere, la sua tradizionale egemonia. Mantiene rapporti di vario tipo, diversi a seconda della configurazione che storicamente ha assunto la sua famiglia e, specie nelle vesti di nonna, assolve compiti preziosi. Dal canto loro, i figli (in special modo, le figlie o le nuore) che vivono fuori di casa assumono mansioni di cura nei confronti dei o di un genitore fragile.
È difficilissimo definire com’è la morfologia della famiglia attuale. Oltre al forte ritocco subito dalla figura del padre, che ha perso i tratti di autorità che possedeva storicamente (oggi, in psicologia lo si arriva a definirlo mammo, perché ha addolcito i suoi comportamenti), forse il suo comune denominatore più evidente è rappresentato dalla fragilità dei legami parentali, perché la convivenza sotto lo stesso tetto pare diventata nel nostro tempo più problematica. Al di là delle difficoltà a stabilire che cos’è oggi l’esperienza della famiglia, possiamo ricorrere all’idea in un certo senso “archetipa” della famiglia come regno della risorsa vitale, degli incontri umani fondamentali, dell’accoglienza sicura e della appartenenza più viva, ma nel contempo come ambito di patologie, di passioni tragiche, di conflitti, di rancori e di ossessioni. Non a caso fin dall’antichità, è stata vista come lo snodo decisivo per il destino delle persone e come il luogo elettivo di tragedie. E non a caso è oggi il luogo dove si perpetua il maggior numero di sopraffazioni, di violenze, perfino di delitti, a partire da quelli contro l’infanzia.
LE PRESCRIZIONI RITUALI AI FIGLI
“A che ora torni?”, “dove vai?”, “con chi esci?”, “non fare tardi”, “hai studiato?”, “scrivimi quando sei arrivato/a”, “vai piano”, “copriti, non prendere freddo”, “non bere/non fumare”, “chiamami”… sono tutte frasi che i genitori ripetono, fin troppo spesso per essere poi efficaci, ai figli adolescenti.
Mezzo secolo fa tutte queste raccomandazioni si condensavano solitamente in due frasi, immancabilmente ripetute ogni qual volta il ragazzo o il giovane usciva: “Fai il bravo.” “Torna in orario.” L’osservanza della prima esortazione era in genere difficile da verificare, al contrario della seconda. Quando, specie di sera, si sforava l’orario prescritto anche per poche decine di minuti, ne seguivano forti rampogne e spesso severe punizioni. E ciò pure se allora non c’erano infide discoteche e pericolosi bar ad attentare alla salute e alle virtù dei ragazzi, che andavamo nei soliti posti, sia in città sia in paese. Inoltre, a monitorare il loro via vai agiva la pratica del pettegolezzo e quella della “genitorialità diffusa” che un tempo metteva (anche positivamente) sotto controllo i figli piccoli e adolescenti quando erano fuori di casa,
Facciamoci due domande: che scopo e che senso avevano queste due direttive? Soprattutto la prima sembrerebbe “una raccomandazione “vuota”. Eppure, “fa’ il bravo” serviva, perché esortava i figli a seguire le regole stabilite dai genitori. Lo stesso scopo, in fondo, era perseguito dalla regola sull’orario: avere in mente l’ora in cui tornare a casa, evocava le norme e la morale genitoriale. E quando l’ordine era rivolto alle figlie, di fatto alludeva alle trasgressioni in campo sessuale
Ma, come si sa, queste violazioni possono essere perpetrate in qualsiasi ora, anche senza la protezione del buio…
LA DOTE
La dote è l'insieme dei beni che la famiglia di una sposa conferisce allo sposo con il matrimonio. In molti Paesi ancora oggi. Così un tempo anche da noi, era obbligatorio portarla allo sposo. Per fare un esempio, la pergamena che elencava i doni conferiti dalla famiglia di Anna Dovara a Filippino Gonzaga, di fatto duca di Mantova, era lunga più venti metri ed elencava una quantità impressionante di beni, in denaro, gioielli, possedimenti terrieri, diritti feudali…
Quella di mia mamma, come dimostra un documento che suo padre aveva depositato in Comune, riguardava solo il corredo, cioè l'insieme degli abiti, della biancheria da casa e degli altri accessori che una sposa portava con sé nella nuova famiglia. Tra le solite cose, menziona alcuni pannolini di lino e, dato che siamo nel 1937, due divise da giovane fascista.
La dote designava in certi casi possedimenti e beni finanziari, ma in genere il corredo di biancheria personale e per la casa la casa (lenzuola, coperte, salviette, tovaglie e utensili) che la sposa portava al marito. Nei secoli passati, la ragazza senza il “corredo” difficilmente trovava marito. Ed è per questo che le suore nei cui conventi erano ospitate ragazze orfane e povere, insegnavano loro a filare la lana, a cucire, a ricamare ciò che avrebbero portato in dote. Ancora per gran del secolo scorso, la dote assumeva la funzione di un obbligo indispensabile che coinvolgeva e riguardava le donne di tutta la famiglia, che sovente erano già molto impegnate nel lavoro dentro e fuori casa. Il corredo era talmente importante che spesso le madri iniziavano a prepararlo appena nasceva un femmina. Ovviamente, le ragazze erano occupate in prima persona a confezionarsi il corredo, sotto la guida di donne di casa, vicine e, quando possibile, dalle suore. La ragazza che cominciava a ricamare il corredo si sentiva più grande e importante.
In ogni modo, la cultura che poi si è imposta ha cambiato i costumi in questo campo, e non a caso il Diritto Civile nel 1975 ha sancito l’abolizione della dote come bene riconosciuto per legge,
Mia moglie, in ogni modo, a metà degli anni 60 mi ha portato in casa un bel corredo. Oggi posso ritrovare in casa mia lenzuola, camicie da notte e federe di lino ricamate in modo egregio (spesso addirittura appartenenti a sua madre e alla mia), ma praticamente inutilizzabili (chi rischierebbe di metterle in lavatrice?). Per fortuna, mia moglie, che sa fare di tutto, ne ha trasformato un paio in due bellissimi abiti estivi, per lei e per mia figlia.
L’ABITUDINE DI CANTARE
Cantavano a squarciagola le ragazze quando rifacevano i letti, e la loro voce, nella bella stagione, usciva squillante dalle finestre aperte. E, quando erano in gruppo, cantavano per le strade, in paese e anche in città (ho testimonianze dirette di questo fatto), di giorno e di sera. Cantavano anche i giovani, da soli a in gruppetti, a piedi e in bicicletta.
Spesso gli uomini adulti all’osteria, intonavano canzoni popolari tradizionali, canti di montagna, oppure politici (quante volte, io che sono cresciuto in un’osteria, mi sono sorbito Bandiera Rossa!). Le canzoni fasciste erano proibite. Mi ricordo che mio padre dovette pagare una multa perché “aveva permesso a un gruppo di avventori di cantare “Faccetta Nera.”
Nelle osterie, qualche volta si cantavano anche arie famose di opere liriche, che allora erano ancora molto conosciute. E le serenate non erano ancora scomparse del tutto. E chi aveva la fortuna di andare sui monti, d’inverno o d’estate, poteva godersi le canzoni di montagna. Le chiese, allora ancora molto frequentate, specie da donne e bambini, risuonavano di canti religiosi. Dato che molti erano in latino, favorivano le storpiature più bizzarre, anche volute, come quando noi bambini trasformavamo, a squarciagola, mundi in mùundui (castagne secche).
Mi ricordo con nostalgia le processioni per il Mese della Madonna, a maggio, per le vie del mio paese, coi canti di centinaia e centinaia di voci (la devozione era tanta, ma, a dire la verità, capitava che i cori perdessero di vigore, perché qualche coppia di giovani e ragazze, approfittando dell’occasione e dalla difficoltà ad esercitare il controllo genitoriale e parentale, sgattaloiavano fuori dal corteo).
L’abitudine di cantare che forse si è perpetuata fino ad ora – per fortuna – è rappresentata dalle filastrocche, cantilene e ninne nanne che mamme, nonne e zie sussurrano e salmodiano ai neonati e ai bimbi piccoli.
LE GOBBE, I GOZZI
Da tempo non vedo più persone con la gobba, che ritrovo solo nel protagonista del Rigoletto, o con il gozzo, quell’ingrossamento della tiroide che ritrovo solo in Gioppino, burattino e maschera bergamasca, che ne ha ben tre e molto grossi. Meglio così, ovviamente.
LA MAIGULA
Compariva soprattutto quando gli adulti minacciavano i maschietti te strìipi, te cavi oppure te taìi la maigula. Essa è interpretata prevalentemente come “ti strappo l’ombelico”, tesi avallata dal gioco degli adulti che fingevano di strappare el luén con le dite, per poi mostrarlo ponendo il pollice tra l’indice e il medio (un giochetto che io faccio con i bambini piccoli, fingendo di estirpare il loro naso, per poi rimetterlo al suo posto).
Per altri, l’oggetto in questione è qualcosa che, un poco più in basso, caratterizza la mascolinità e la cui estirpazione costituisce dai tempi dei tempi una minaccia cruciale. Io condividevo questa tesi minoritaria con gli opinion leader del mio ristretto gruppo di amici (ovviamente, tutti maschi), inconsapevoli ma pervicaci assertori della tesi freudiana del complesso di castrazione: per noi bambini ciò che era minacciato era el piséen, termine che designava il membro maschile dei bimbi piccoli. Avallava queste interpretazione il fatto che in bresciano e in bergamasco maigula indicava la una radice lunga e sottile, difficile da estirpare, una carota selvatica”. Il grande scrittore Luigi Meneghello (in Pomo pero, Mondadori, Milano, 1987, p. 11) ha scritto una bellissima pagina su questa tematica.
LA PETÈERA
Indicava il fondo dei pantaloni troppo larghi e cadenti. Ma nella mia infanzia, ed era al centro della frase “Te ghèt a mo’ la petèera” poste sui pantaloni (sei ancora piccolissimo), si riferiva alle pezze di tessuto sul sedere dei bambini poveri. La povertà e la carenza di indumenti rendeva difficile sostituire i calzoncini dei bambini, soggetti a continue lordure sul didietro, per cui si ovviava tagliando la stoffa sul sedere e si mettendo al suo posto, attaccata con quattro bottoni, una delle pezze prese da tanti tipi di indumenti, che erano assai più facilmente reperibili, lavabili e sostituibili.
L’eco di questo uso lo ritroviamo molti decenni dopo, quando fra i ragazzi erano di moda jeans col fondo cadente, e noi adulti li chiamavano “braghe alla cacaiola”
EL CIBALO
È una sottspecie di torrone a base di arachidi da sempre considerato il parente povero del ben più famoso torrone alle mandorle, che originariamente veniva venduto sulle bancarelle e noto ai più grazie alla carovana che seguiva il Giro d'Italia nel primo dopoguerra. Era colloso e difficile da masticare, per cui questa operazione, oltre che i denti, si diceva che indolenziva perfino “el butàon del còl”.
Mi vengono in mente tante altre cose, delle quali faccio cenno solo a quelle più curiose: l’attribuzione a tutti, singoli e famiglie, del soprannome; la fatica a confessare al prete nel confessionale certe pratiche di autoerotismo intensamente reiterate da noi maschietti; i pescatori di professione; i calessi coi loro cavalli; i buoi per trainare carri e aratri; le tante cose che si poteva trovare nei boschi, nei fiumi, negli stagni (legna pesci, rane, funghi beni preziosi in un tempo in cui era ancora importate l’economia di sussistenza), il rito cruento dell’uccisione del maiale; la vendemmia e la pigiatura dell’uva. E ancora: il nome paterno sulle carte d’identità, le pagelle… con l’odiosa sigla NN a marchiare i figli di ragazze madri, la diffusione del vino marsala, soprattutto tra le donne, la chierica, rasatura a forma di piccolo cerchio sulla sommità del capo dei preti ... – ma il discorso diverrebbe troppo lungo.
(foto Fazioli)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
















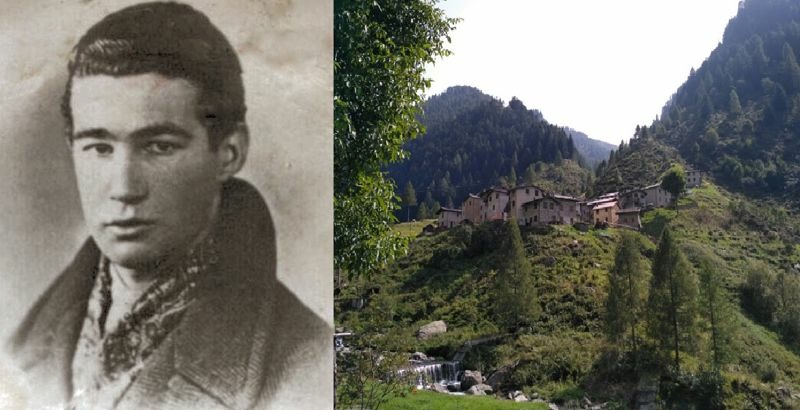





















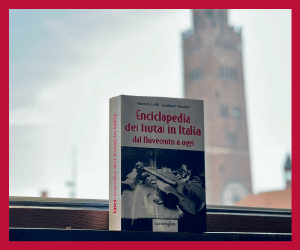







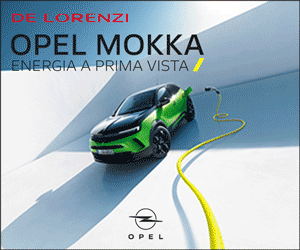


commenti
ennio serventi
8 agosto 2021 13:53
fra le cose che che per fortuna non ci sono più Gianvi ha dimenticato di mettere anche le due divise di "giovane fascista". E' stata necessaria la guerra partigiana per toglierle da una qualsiasi dote.
Pietro Ferrari
8 agosto 2021 19:16
La " Pezera" era chiamata dalle nostre mamme per spaventarci e cercare di farci dormire