Shoah e Nakba. Ricordare per una positiva pedagogia della memoria
Ricordare è un diritto e anche un dovere. Ma è sempre così? Un lutto troppo protratto nel tempo non può diventare un’infezione dei corpi e degli animi? Ed è giusto tagliare pezzi di memoria, per risaltare solo ciò che ci piace? La recentissima lettura di un libro estremamente coraggioso e originale (Olocausto e Nakba. Narrazioni tra trauma e storia, Zikkaron, 2023) ha sollecitato in me alcune riflessioni sulla “pedagogia della memoria”, aprendomi ad una visione meno banale di quell’enorme tragedia rappresentata dal conflitto in Palestina, giunto ora ad una fase più terribile.
L’evento cruciale nel racconto di Edith Bruck “Il pane perduto” (La nave di Teseo, 2021) è la lievitazione del pane nel corso della notte, ma all’alba arrivano i nazisti, che catturano tutta la famiglia per deportarla insieme agli altri ebrei del villaggio ungherese. Un semplice episodio di deportazione, con il pane preparato dalla madre, che si è costretti ad abbandonare in casa, senza poterlo cuocere, portare con sé, sfamarsene per scaldarsi il cuore. “La madre parlava delle pagnotte da infornare mentre buttava alla rinfusa dei vestiti nell’unica valigia e nei sacchi. Ditke cercava la sua bambola che, nella confusione, non si sa come, era finita schiacciata sotto una delle ciotole con la pasta da lievitare”.
Questa pagina mi è tornata drammaticamente alla memoria quando ho trovato un episodio analogo in un altro testo, che riporta ciò che disse Golda Meir, una delle leader del nascente stato d’Israele, che visitò la zona araba di Haifa ai primi di maggio 1948 dopo la battaglia: «c’erano case dove erano rimasti il caffè e il pane arabo sul tavolo, e non ho potuto evitare [di pensare] che questa era stata in effetti la stessa scena in molte città ebraiche [in Europa ai tempi dell’Olocausto]». Ciò che colpisce in tale episodio è l’assoluta indifferenza verso la tragedia altrui, che le appare un nulla rispetto al diritto assoluto degli Israeliani di fondare e difendere il loro stato. Un atteggiamento fatto proprio dalla maggioranza dei cittadini di Israele.
Non tutti gli ebrei israeliani, però, reagirono così. Genya scampata col marito Henryk Kowalski al forno crematorio e giunta in Israele, a cui l’Agenzia ebraica aveva assegnato una casa molto bella a Giaffa, ricorda. “Aprimmo e rimasi scioccata, mi ricordò come eravamo stati costretti a partire, tutto era abbandonato. I piatti sul tavolo. Faceva paura… I tedeschi ci hanno sbattuti nel ghetto e ora volevano darci una casa di arabi che se ne erano andati con il cibo ancora sul tavolo. A noi avevano fatto la stessa cosa… Non voglio vivere nella casa di gente che è stata buttata fuori. Per me un essere umano è un essere umano”. Restituirono le chiavi. Scrive Alon Confino, che riporta questo episodio: “Non era il risultato di una decisione o di un’analisi, ma nasceva piuttosto dalla loro stessa esistenza fisica di vittime, dalla loro cruda esperienza e dalle cicatrici del ricordo”. Pure in minoranza, anche vari autori ebrei scrissero: «Tra i migliori dei nostri compagni si è insinuato il pensiero che forse è possibile conseguire il nostro radicamento nella terra di Israele dal punto di vista politico anche con mezzi nazi-hitleriani». A me si è accapponata la pelle.
D’altra parte, se nelle lotte senza quartiere negli anni 1947-1948, o nella guerra dei sei giorni del 1967, avessero visto la vittoria delle forze arabo-palestinesi, quale sarebbero state le conseguenze per la popolazione ebrea già arrivata da tutto il mondo? Si può pensare che sarebbe stata trattata con metodi meno “nazi-hitleriani”? Che avrebbe avuto un destino meno tragico degli Armeni in Turchia?
Già accostare i due termini, Olocausto e Nakba, che portano alla luce il concetto di “catastrofe” di interi popoli, può rappresentare qualcosa di offensivo, che la maggioranza sia dei palestinesi che degli israeliani rifiutano. Eppure a scrivere il testo sono due autori, Bashir Bashir e Amos Goldberg, rispettivamente ebreo-israeliano e israeliano-palestinese, i quali si sono proposti coscientemente di mettere in crisi narrazioni identitarie e fondative, che alimentano guerre e attentati, annullando la sensibilità verso la sofferenza dell’altro.
Secondo il loro parere, Shoah e Nakba hanno assunto, nelle narrazioni contrapposte, il ruolo di tratti identitari, passati fondanti, traumi scelti da entrambi i popoli per sapere chi sono e quale è il loro perenne nemico. “Entrambi sono, quindi, identità nazionali in cui la dimensione della catastrofe e del trauma svolgono un ruolo centrale e dove la narrazione nazionale ruota in gran parte attorno a motivi legati all’essere vittime e alla perdita subita. Ciascuna parte è convinta di essere la vittima finale della storia, mentre nega o minimizza la sofferenza dell’altra parte per avvalorare la propria posizione”. E le proprie atrocità, aggiungerei.
Per tale ragione i due popoli stanno abbarbicati alla propria “catastrofe”, in quanto il suo ricordo, il suo continuo racconto, permette loro sentirsi “popolo” e di giustificare le crudeltà anche efferate compiute a più riprese nei confronti del popolo avverso, allontanando da sé ogni senso di colpa. Narrazioni della propria “catastrofe”, per anestetizzare il senso di colpa della ferocia con cui, appena possono, colpiscono l’altro. Non va dimenticato, ad esempio, che dal 1990 al 2010 si sono verificati più di un centinaio di attentati terroristici di musulmani o palestinesi contro ebrei o istituzioni israeliane, sempre “giustificati” dal sangue palestinese versato da Israele. Risultati politico-militari raggiunti? Nulli, se non il rafforzamento dell’ala oltranzista israeliana. Violenza che genera violenza, mai riflessione etica, giungendo così all’aberrazione del 7 ottobre 2023 compiuta da Hamas.
Gli autori di questo testo, al contrario, con la pubblicazione collettiva a cui hanno partecipato una quindicina di studiosi di varia nazionalità e convinzioni, arabi e israeliani, vorrebbero “Spazzolare la storia contropelo” (usando la famosa espressione di Walter Benjamin), cioè proporre “un altro registro della storia e della memoria, che onori l’unicità di ogni evento, le sue circostanze e conseguenze, le differenze, ma offra anche un quadro storico e concettuale comune, all’interno del quale possano essere trattate entrambe le narrazioni.”
Cambiare la lingua delle narrazioni contrapposte: questo il loro proposito. “Noi riteniamo che la visione del mondo dicotomica ed esclusiva offerta dalle tradizionali narrazioni nazionali, sebbene sia profondamente radicata e costituisca una forza potente nella formazione delle opposte identità nazionali di ebrei e palestinesi, sia viziata sul piano storico e dannosa su quello politico ed etico”. Quali sono queste narrazioni dominanti e contrapposte di cui vivono i due popoli, esplicitamente elaborate o nascoste nella profondità della mente e del loro subconscio?
1 – La nascita dello Stato israeliano come risarcimento dovuto agli ebrei per l’Olocausto subito. Come scrivono i nostri autori, la narrazione della Shoah, che viene ripetuta infinite volte fino a diventare egemonica in tutto l’Occidente, rimarca che gli ebrei sono stati le vittime principali dei nazisti, l’incarnazione del male più orribile e radicale della storia moderna, a cui non si può paragonare altra tragedia. Lo sterminio degli ebrei non è stato casuale, ma il risultato più estremo dell’antisemitismo, la conseguenza della lunga storia dell’odio nei confronti degli ebrei nell’Europa cristiana. Questi eventi fondano la necessità di uno Stato ebraico, rendendo legittimo il sionismo, per cui l’istituzione anche con la forza dello Stato di Israele diviene il risarcimento del debito inevitabile e doveroso spettante alle vittime del nazismo.
Si è giunti perfino, aggiungiamo noi, ad emanare una Legge Fondamentale (luglio 2018) per rendere assoluto il diritto israeliano a quella terra, senza mai pensare ai diritti degli altri popoli in Palestina: “Lo Stato di Israele è la patria nazionale del popolo ebraico, in cui esercita il suo diritto naturale, culturale, religioso e storico all’autodeterminazione”. Israele «vede lo sviluppo dell’insediamento ebraico come valore nazionale e agirà per incoraggiare e promuovere il suo consolidamento». Una formulazione che è una tacita dichiarazione di guerra permanente. Tale norma sollevò la contrarietà dell’allora presidente d’Israele Reuven Rivlin soprattutto là dove sancisce che l’auto-determinazione nazionale nello Stato di Israele è un diritto esclusivo del popolo ebraico.
2 – La nascita dello Stato d’Israele come ultimo episodio del colonialismo occidentale. La narrazione arabo-palestinese richiama invece la più ampia cornice storica, nella quale il sionismo è visto come insediamento in Palestina non dissimile alle politiche europee in Africa e in Asia, e lo stato di Israele come l’ultimo dei regimi coloniali dell’Occidente. Nel clima politico tra le due guerre mondiali e nelle ripercussioni di circostanze storiche specifiche come la Shoah, il sionismo è riuscito a sfuggire alla condanna della colonizzazione di quei decenni e ha continuato a commettere tutti i crimini di un insediamento coloniale che tende apertamente o nascostamente, consciamente o inconsciamente, a impadronirsi del territorio degli abitanti originari tramite la loro espulsione o addirittura la loro eliminazione. La Nakba è un ulteriore esempio dei crimini dell’insediamento europeo in molte aree del mondo, e la memoria della Shoah serve a rafforzare la discutibile alleanza tra il Sionismo e Occidente, che ha condannato i Palestinesi.
Tali narrazioni contrapposte sono tese a fondare il diritto alla propria assoluta ragione e ad eliminare ogni sensibilità nei confronti del dolore dell’altro, che viene del tutto sottovaluto e financo negato. E le rispettive diaspore di fatto dimenticate dal “nemico”. Quella più nota degli ebrei nei secoli provocata dai Romani, a cui sono seguite infinite altre cacciate e persecuzioni, tra cui quella tragica dei Sefarditi dalla Spagna nel 1492, e quella spesso dimenticata dei Palestinesi, una popolazione di circa 5 milioni di individui sparpagliati in tutto il Medio oriente e nel mondo intero dopo il 1948 e che continua tuttora. Ma il diritto a diventare spietati col vicino non potrà mai essere conquistato. Non si può, come uomini, rivendicare il diritto a diventare “disumani”.
Da qui il dovere di sviluppare una “pedagogia della memoria”, nella quale in ogni situazione di conflitto è importante la “conoscenza dell’altro”, ma in particolare è fondamentale il riconoscimento del “dolore dell’altro”. La pedagogia della memoria è quell'insieme organico di teorie, saperi, pratiche, racconti che riflettono su come l'educazione della memoria possa contribuire al pieno dispiegamento delle potenzialità di quelle comunità che non vogliono chiudersi in sé, ma desiderano ridisegnare il passato per aprirsi alla speranza.
Le narrazioni richiamate dovrebbero spingere ognuno a conquistare uno sguardo dall’alto, non cancellando un attributo di Dio nelle tre religioni del Libro: la “misericordia”, che laicamente si chiama pietas. Cito a questo proposito un documento, del 1986, di Giuseppe Dossetti, uno dei padri costituenti, che, ordinato sacerdote, visse dopo il 1972 per lunghi anni in Palestina, a Gerico, nei territori occupati da Israele alla ricerca delle più profonde originarie radici cristiane.
Il suo Cenobio era collocato su una frontiera contesa: “Da un lato è in me la memoria indelebile dell’Olocausto ebraico e un’apertura e una sensibilità consonanti con la grande tradizione dell’Israele eterno, l’Israele spirituale, che ritengo ancora necessario al Cristianesimo e alla Chiesa per auto-comprendersi e per vivere con totale coerenza e fedeltà la propria missione in noi. Dall’altro è la lucida e aperta consapevolezza che il mondo intero, specialmente il nostro mondo occidentale, forse prima, e più ancora che lo stesso stato di Israele, ha commesso e continua a commettere nei confronti degli arabi-palestinesi un’enorme ingiustizia qualunque sia il loro errore o la loro colpa; e che la pace, nello stesso interesse dello stato di Israele, non potrà esservi senza una riparazione effettiva delle ingiustizie consumate e senza la restituzione di una parte dei territori ad un popolo conculcato e da tutti i lati spinto alla disperazione” (“Discorso dell’Arciginnasio”).
Solo il racconto e il ricordo delle sofferenze dell’altro possono porre le basi per un incontro, in modo da passare dalla comprensione del dolore altrui alla necessità del pentimento e del perdono in vista della pace. Esistono situazioni nelle quali entrambi i contendenti hanno ragione, da un certo punto di vista. Si profila qui un contrasto tra il dovere della memoria, irrinunciabile oggi, e la necessità dell’oblio, per il futuro. La memoria, per non diventare coazione a ripetere errori e tragedie, va iscritta nell’orizzonte del futuro, per ridare senso a un progetto di umanità dialogante e rispettosa delle diversità. Anzi è il progetto di futuro che ci aiuta a scegliere quali le memorie da onorare e quali da seppellire allontanandole da sé.
PS. Palestinesi ed Ebrei sono “affratellati” dal destino da un altro particolare simbolico. Gli uni sono per religione “mussulmani” - coloro che si sottomettono totalmente alla volontà di Dio. Gli altri erano chiamati con questo nome ad Auschwitz: “Era comune a tutti i Lager il termine Muselmann, “mussulmano”, attribuito al prigioniero irreversibilmente esausto, estenuato, prossimo alla morte” (Primo Levi).
© RIPRODUZIONE RISERVATA

















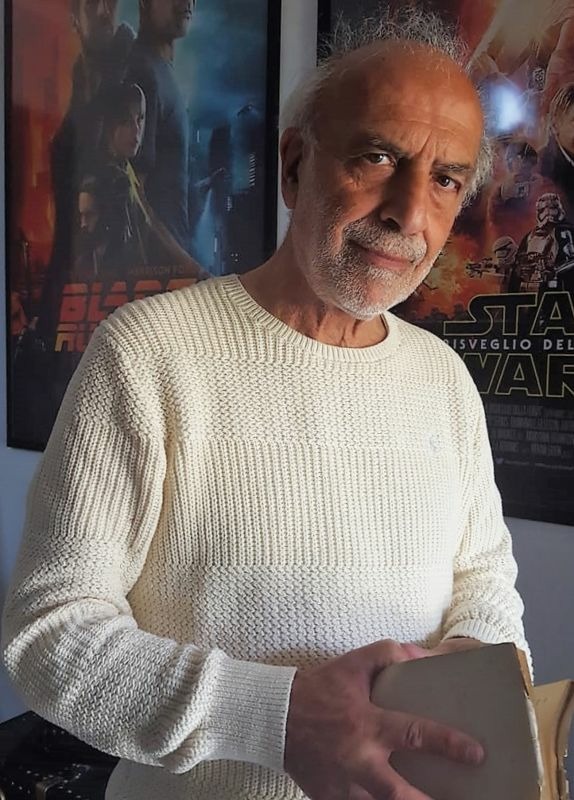
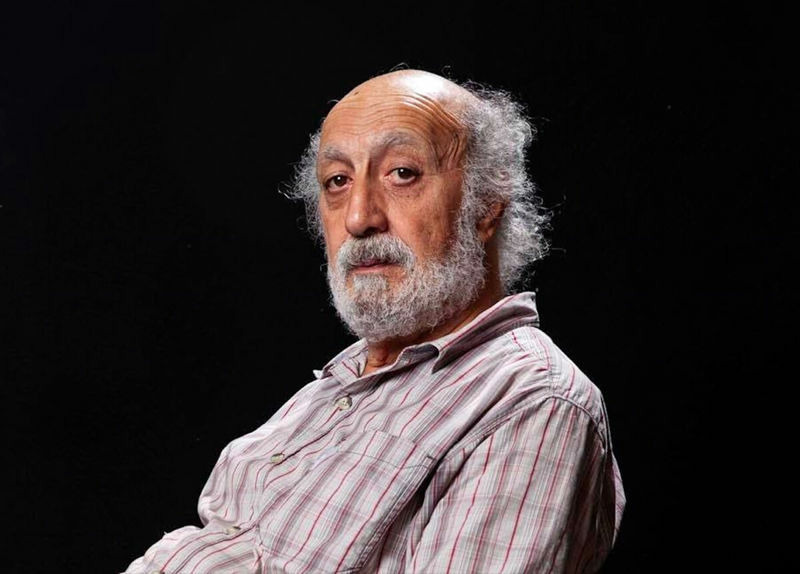









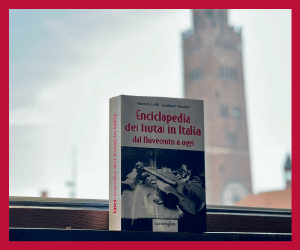



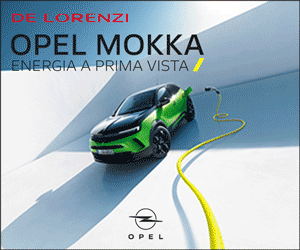







commenti